|
|
|
|
|
PROGETTO FIUME PO Acquisizione di dati, sperimentazione di metodologie geofisiche e valutazione del loro impatto ambientale sul Fiume Po |
||
|
|
|
|
|
PROGETTO FIUME PO Acquisizione di dati, sperimentazione di metodologie geofisiche e valutazione del loro impatto ambientale sul Fiume Po |
||
CAPITOLO 1: PROGETTO FIUME PO
1.1 INTRODUZIONE 2
1.2 OBIETTIVI DEL PROGETTO 3
1.3 INQUADRAMENTO GEOLOGICO 4
1.4 IDRODINAMICA DEL FIUME PO E RETE IDROMETRICA 6
1.5 SOCIETÀ ED ENTI DI RICERCA COINVOLTI NEL PROGETTO 15
1.6 COLLABORAZIONI 16
1.7 CALENDARIO DELLE OPERAZIONI E PERSONALE 18
Il progetto “Fiume Po”, nato in origine (1991) con l’obiettivo di registrare una linea sismica lungo l’alveo del fiume Po per risolvere l’annoso problema dell’assenza di copertura nel grigliato sismico in corrispondenza degli attraversamenti dello stesso, è venuto configurandosi, in fase realizzativa, come un vasto progetto capace di coniugare obiettivi industriali con quelli di pura ricerca scientifica e di fornire risultati e dati di ampio interesse pubblico.
Il progetto è stato realizzato in ambito di Convenzione di Ricerca Scientifica stipulata tra ENI-Div. AGIP, CNR e Regione Emilia Romagna.
Questa sinergia ha permesso di collocare la questione sismica in un ambito scientifico-sperimentale che si è avvalso, tra l’altro, della partecipazione dell’Università di Ferrara, dell’ARNI, Enti Pubblici e società di Servizi.
Il progetto si è articolato in tre fasi principali: (1) rilevamento della batimetria e della morfologia del fiume in una fascia centrata sulla linea di navigazione tracciata da ARNI e studio delle ciclicità comportamentali del regime idrodinamico, (2) valutazione dell’impatto della sorgente sismica sulla fauna ittica, sulle sponde, sugli argini e sui manufatti, (3) acquisizione della linea sismica 2D in alveo in condizioni di sicurezza e tutela ambientale.
La fase di pianificazione dell’intero progetto ha richiesto circa un anno mentre quella esecutiva, affidata alla società G.A.S. di Bologna, è stata completata in meno di 3 mesi; gli elaborati finali hanno invece richiesto circa un anno di lavoro.
I dati raccolti ed elaborati sono stati organizzati in tre volumi ed in un CD-Rom. Il primo volume comprende il rapporto finale in cui i risultati del lavoro sono corredati da alcuni elaborati grafici, quali carte e profili batimetrici, esempi di registrazioni Side Scan Sonar e Sub Bottom Profiler, fotografie sezioni sismiche multicanale interpretate; i volumi 2 e 3 contengono invece tutti gli allegati cartografici in scala 1:5000 e con dettagli a scala 1:1000.
Gli obiettivi che il Progetto Po ha inteso perseguire sono:
sperimentazione di metodologie di acquisizione sismica tipo “offshore” in ambiente fluviale;
valutazione dell’impatto ambientale delle operazioni di prospezione sismica;
mappatura del fondo del fiume: batimetria e morfologia su una fascia, a larghezza variabile, centrata sulla linea tradizionale di navigazione tracciata da ARNI;
definizione, attraverso l’interpretazione della sezione sismica, delle geometrie deposizionali e strutturali delle unità litostratigrafiche del sottosuolo finalizzate alla valutazione di risorse idriche e petrolifere.
Il tratto di Fiume Po oggetto di studio insiste sulle strutture esterne del margine appenninico-padano (“Dorsale Ferrarese” di Pieri e Groppi, 1981 e segg.), sull’avanfossa appenninica plio-quaternaria e sull’avampese indeformato (Fig. 1.3).
La serie plio-quaternaria di avanfossa, che localmente supera gli 8000 metri, è costituita da unità clastiche prevalentemente torbiditiche.
Il substrato di questa serie è costituito da una serie prevalentemente pelitica di età paleocenica-miocenica di spessore ridotto deposta in un contesto di avampeaese comune alle catene appenninica e sudalpina.
La serie sottostante, costituente l’impalcatura della Dorsale ferrarese, è rappresentata da unità carbonatiche mesozoiche deposte in un contesto di tettonica estensionale.
Il tratto più occidentale indagato (Ostiglia - Sermide) è ubicato ai margini di uno dei principali depocentri dell’avanfossa appenninica (interarco tra le strutture emiliane e quelle ferraresi), ove la serie plio-quaternaria è prossima ai 300 metri di spessore.
Da Sermide a Ficarolo il fiume attraversa le strutture più esterne della Dorsale Ferrarese e tra Ficarolo e Pontelagoscuro corre parallelamente all’asse della struttura più rilevata dell’arco, coinvolgendo, oltre alle unità clastiche terziarie, le unità carbonatiche mesozoiche.
Nel tratto successivo (Pontelagoscuro - Polesella) attraversa ortogonalmente gli assi delle strutture appenniniche e da qui al Delta segue l’asse dell’avanfossa nel verso della sua inflessione assiale.
In questo paragrafo verrà trattata sommariamente l’idrodinamica del F. Po dalla relazione di ARNI e CAIRE (1992), insieme ad una discussione sulla rete idrometrica.
Il Po, il maggiore dei fiumi italiani, nasce dal Monviso a 2022 m s.l.m. e sbocca con un ampio delta nel mare Adriatico dopo avere percorso 673 Km, lungo un tracciato che segue la direzione W-E da Torino fino alla foce. La sua idrografia presenta un ricco ventaglio di affluenti che scendono in riva destra dagli Appennini, con percorso breve e ripido, e in riva sinistra dalle Alpi, con percorsi piu’ lunghi (Fig.1.4a). Il bacino imbrifero del Po ha una superficie di 70091 Km2 ed un contorno che segue lo spartiacque degli Appennini e delle Alpi, chiudendosi tuttavia prima di arrivare al mare, a notevole distanza dalla foce:
- in sinistra, alla confluenza del Mincio, 165 Km a monte della foce;
- in destra a foce Panaro, 111 Km a monte della foce.
Gli affluenti alpini alimentano il Po di acque chiare, con portate regolari, mentre quelli appenninici hanno invece regime nettamente pluviale e generalmente caratterizzato da elevato trasporto solido.
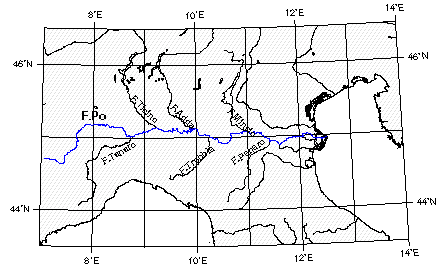
Fig. 1.4a - Il Fiume Po ed i suoi principali affluenti
I valori progressivi delle superfici dei bacini imbriferi sottesi dalle principali sezioni sono elencati in Tab.1.4a, che riporta anche le altezze degli afflussi meteorici e dei deflussi nell’anno medio.
|
Sezione |
Distanza dalla foce (km) |
Superficie Bacino imbrifero (km2) |
Afflussi (mm) |
Deflussi (mm) |
Portata media (m3/sec) |
|
Becca (anno medio) |
387 |
36770 |
1125 |
670 |
808 |
|
Piacenza (1924-1984) |
327 |
42030 |
1147 |
737 |
982 |
|
Cremona (1971-1984) |
290 |
50726 |
1223 |
817 |
1314 |
|
Boretto (1942-1984) |
220 |
55183 |
1148 |
715 |
1251 |
|
Borgoforte (1924-1984) |
187 |
62450 |
1148 |
720 |
1426 |
|
Pontelagoscuro (1918-1984) |
91 |
70091 |
1121 |
680 |
1513 |
Tab. 1.4a - Fiume Po - Superficie del bacino imbrifero, afflussi meteorici e deflussi delle sezioni principali di misura (anno medio)
Il bacino è ricco di precipitazioni, con un valore medio annuale degli afflussi meteorici sull’intero bacino di 1121 mm. La distribuzione stagionale degli afflussi è equilibrata. Il regime naturale del Po presenta infatti due periodi di magra, in inverno e in estate, e due periodi di piena nelle altre stagioni. La regolazione delle portate che viene effettuata con la manovra dei numerosi serbatoi idroelettrici (2340 milioni di m3) ha aumentato le portate invernali, mentre la regolazione dei grandi laghi prealpini (1420 milioni di m3) che viene effettuata con lo scopo principale di assicurare acque ad uso irriguo, ha ridotto gli effetti negativi del fortissimo prelievo per l’agricoltura. Anche la piena primaverile è sensibilmente mitigata dalla disponibilità dei volumi di invaso dei serbatoi idroelettrici, che escono dall’inverno generalmente vuoti. Se si mettono a confronto i deflussi disponibili nel semestre irriguo aprile settembre dell’anno medio, dopo aver soddisfatto i prelievi per le irrigazioni, si ottiene una disponibilità di 336 mm a Pontelagoscuro, pressoché uguale a quella del semestre non irriguo. Se si considerano le portate medie riferite ai quattro trimestri dell’anno medio, alla sezione di Pontelagoscuro, si trovano valori che testimoniano una pronunciata stabilita’ idraulica (Tab. 1.4b).
|
Trimestre |
Portata (m3/sec) |
|
1 |
1363 |
|
2 |
1817 |
|
3 |
1170 |
|
4 |
1697 |
Tab.1.4b - Fiume Po - Portata media riferita ai quattro trimestri dell’anno medio.
|
Durata (gg/anno) |
Boretto |
Pontelagoscuro |
|
10 |
3710 |
4160 |
|
30 |
2470 |
2920 |
|
60 |
1870 |
2250 |
|
91 |
1510 |
1850 |
|
135 |
1190 |
1480 |
|
182 |
966 |
1810 |
|
274 |
678 |
872 |
|
355 |
385 |
468 |
Tab. 1.4c - Fiume Po - Durata delle portate nell’anno medio (m3/sec) alle sezioni di Boretto e Pontelagoscuro
Nella Tab. 1.4d sono riportati i valori della pendenza media del pelo libero dalla Becca alla foce.
|
Tratto |
Pendenza media (cm/km) |
|
Becca-Piacenza-Isola Serafini |
18.7 |
|
Isola Serafini-Cremona-Boretto |
14.3 |
|
Boretto-Roncocorrente |
14.2 |
|
Roncocorrente-Pontelagoscuro |
11.9 |
Tab. 1.4d Fiume Po - Valori della pendenza media del pelo libero.
Nel tronco medio inferiore, la forma tipica dell’alveo del Po presenta:
- Un alveo maggiore, compreso fra gli argini maestri, con larghezze variabili fino a valori che sono, per lunghi tratti, superiori ai 2000 m, e che arrivano fino a massimi di 5000 m. Nell’alveo maggiore sono comprese ampie aree golenali, che vengono coltivate soprattutto con boschi di pioppo e che vengono allagate al passaggio delle piene maggiori. Talora, questi terreni coltivati sono difesi da argini secondari, che hanno la funzione di proteggere i raccolti, riducendo la frequenza degli allagamenti con tempi di ritorno di circa 10 anni.
- All’interno dell’alveo maggiore si trova un alveo medio, inciso rispetto al livello delle golene coltivate, di larghezza variabile attorno a valori di 450-500 m.
RETE IDROMETRICA E PARAMETRIZZAZIONI DEL LIVELLO DELL’ACQUA
Il fiume Po è controllato nel suo regime idraulico dal Magistrato del Po e dai suoi Uffici Periferici, tramite una serie di idrometri, a lettura manuale, registranti e, da poco, con trasmissione in tempo reale ogni ora (telerilevati). Questi idrometri permettono di ricavare nel tempo la altezza del pelo dell’acqua sul livello Medio mare, e, quindi, di permettere il riporto s.l.m. dei rilievi che sono effettuati lungo l’asta. Particolare importanza assumono gli idrometri telerilevati nella vicinanza della foce, dove è massima l’oscillazione del livello a causa della marea Adriatica, le cui ampiezze possono essere dell’ordine del metro.
Nel corso del presente lavoro sono stati presi in considerazione tutti gli idrometri disponibili (a lettura manuale e telerilevata) nel tratto da Borgoforte alla foce (Fig. 1.4b, Tab. 1.4e).
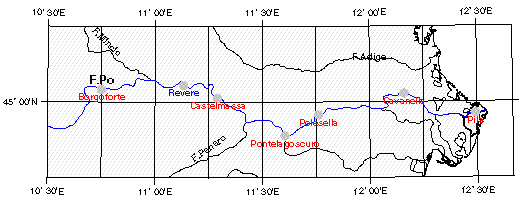
Fig. 1.4b - Fiume Po - Rete idrometrica Telerilevata (rosso) e manuale (blu).
|
LOCALITA’ |
TIPO |
ZERO S.L.M. |
LIV. MAGRA S.L.M. |
EST |
NORD |
DISTANZA LUNGO ASTA |
|
BORGOFORTE |
TELERILEVATO |
14.69 |
12.91 |
1637833 |
4989161 |
-170000 |
|
REVERE |
MANUALE |
9.48 |
|
1668000 |
4991500 |
-139234 |
|
CASTELMASSA |
TELERILEVATO |
4.38 |
6.36 |
1680645 |
4987145 |
-120340 |
|
CASTELMASSA |
MANUALE |
7.38 |
|
|
|
|
|
PONTELAGOSCURO |
TELERILEVATO |
8.18 |
2.64 |
1705750 |
4973900 |
-86103 |
|
PONTELAGOSCURO |
MANUALE |
8.11 |
|
|
|
|
|
POLESELLA |
TELERILEVATO |
-1.64 |
1.28 |
1717800 |
4981950 |
-69396 |
|
CAVANELLA |
TELERILEVATO |
0.0 |
0.0 |
1749000 |
4991000 |
-30625 |
|
PILA |
TELERILEVATO |
-0.13 |
-0.13 |
1775400 |
4984800 |
0 |
Tab. 1.4e - Rete Idrometrica utilizzata nel presente lavoro
Nel corso del 1997 l’Ufficio Periferico del Magistrato del Po di Rovigo ha effettuato una livellazione sugli idrometri telerilevati di Castelmassa, Pontelagoscuro, Polesella, Cavanella e Pila, e ha corretto la misura degli stessi riportandola al livello medio mare.
I rilievi del presente lavoro sono stati eseguiti da settembre a dicembre 1996. Nella Fig. 1.4c viene riportata la lettura dell’idrometro di Castelmassa. I rilievi batimorfologici (batimetria e “side scan sonar”) sono stati eseguiti in un periodo di magra, col passaggio di una leggera perturbazione che ha provocato una cosiddetta “morbida” di circa 1 metro. Invece, i rilievi sismici sono stati eseguiti al passaggio di una piena di media intensità. Il mese di novembre ha visto il passaggio di due piene considerevoli.
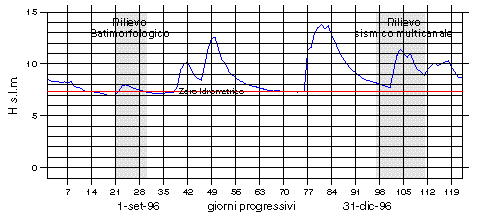
Fig. 1.4c - Lettura dell’idrometro manuale di Castelmassa (settembre - dicembre 1996) (cortesia dell’Ufficio periferico di Rovigo del Magistrato del Po).
Allo scopo di fornire una indicazione quanto più possibile realistica della batimetria del fiume, è necessario definire la superficie alla quale riferire i dati di profondità acquisiti. Tale superficie si modifica nel tempo e nello spazio, a causa dell’innalzamento dell’alveo sul livello medio mare, man mano che si procede verso monte, e delle variazioni di livello del fiume, e, alla foce, a causa dell’interazione fiume-mare. Quest’ultima è modulata sulle fasi diurne e semidiurne dalla marea e, a periodi più lunghi, oppure ad impulsi, dalle configurazioni assunte dal sistema terra-luna-sole e dal passaggio di perturbazioni nel bacino Adriatico, con variazioni significative del livello medio del mare.
Un corretto riporto del dato sul livello medio mare implica quindi una valutazione quanto più possibile accurata degli zeri degli idrometri, la cui lettura viene utilizzata per la correzione di profondità al dato istante e posizione in funzione del tempo e della distanza fra i due idrometri più vicini. Inoltre, è necessario valutare la forma che assume il livello dell’acqua ad un tempo prefissato. Tipicamente, per scopi batimetrici, è d’uso riportare il dato misurato al livello più basso che può assumere l’acqua nel tempo. In mare, ad esempio, viene utilizzato il livello più basso delle basse maree sizigiali. Nel caso specifico del Fiume Po, potrebbe essere una scelta opportuna riferire i dati ad un livello di magra che possa considerarsi statisticamente significativo. Per la costruzione delle curve ipsografiche dell’altezza dell’acqua, è necessario trasferire i dati di posizionamento dallo spazio E,N ad un asse di distanze progressive lungo l’asta rettificata del fiume.
Tramite la digitalizzazione degli argini fluviali, e di una linea mediana a passo 50 m entro tali argini, si è costruito tale asse delle distanze, con punto origine il centro fiume all’altezza dell’Idrometro di Pila (asse positivo verso mare), e calcolando per ogni punto di coordinate E,N della linea mediana la distanza progressiva dall’origine con
![]()
![]()
Gli idrometri considerati vengono riportati lungo tale asse mediante la loro appartenenza a punti della linea mediana oppure entro la congiungente di due di questi punti, con i dati delle coordinate E,N e della distanza dall’origine a Pila riportati in tabella 1.4e.
In tale sistema di riferimento, possiamo vedere in Fig. 1.4d la forma media assunta dal livello dell’acqua in un periodo di magra pronunciata, da Revere alla foce (Pila) (dati luglio 1997, marzo 1998, cortesia Magistrato del Po a Parma), in funzione della distanza lungo l’asta fluviale. Questo livello potrebbe essere considerato un buon riferimento per i dati batimetrici (riferiti al livello dell’acqua), fermo restando che la quantità di dati a disposizione dovrebbe essere molto maggiore per aumentare la significatività statistica dell’analisi.
Per dare continuità spaziale alla curva ipsometrica è possibile operare con interpolazioni polinomiali o “spline”, oppure, attraverso la modellazione di curve empiriche, vedi ad esempio Mosetti (1979), pag.63. Nella Fig.1.4.d si puo’ vedere il risultato di una interpolazione dei dati idrometrici con un polinomio di 6o grado, che, per il tratto di distanza interessato, è in buon accordo con le osservazioni. Il calcolo è stato fatto utilizzando le routines ‘polyfit’ di IDL (1995) e MATLAB (1996), che hanno fornito gli stessi risultati a meno della 6a cifra decimale. È da notare come la funzione interpolante non sia in grado di calcolare al meglio i dati osservati di Cavanella e Pila. L’errore ipotizzabile è dell’ordine dei 10 cm. Purtroppo nel tratto fra Cavanella e Polesella, dove si ha lo smorzamento della onda di marea, non sono disponibili dati idrometrici, per cui è abbastanza rischioso fare ipotesi basate su modelli fisici. Il ‘best fit’ si è ottenuto con un idrometro virtuale a -50 Km da Pila, con altezza dell’acqua a 0.25m s.l.m. È interessante notare che la quota minima a Pila è molto prossima allo zero batimetrico dell’Istituto Idrografico della Marina per la zona della foce del Po (-0.40 s.l.m.). Con tale funzione è possibile generare una superficie di riferimento da sottrarre ai dati di altezze s.l.m per il riporto al livello dell’acqua. Con ciò si ottengono carte batimetriche per ogni punto dell’asta fluviale interessato.
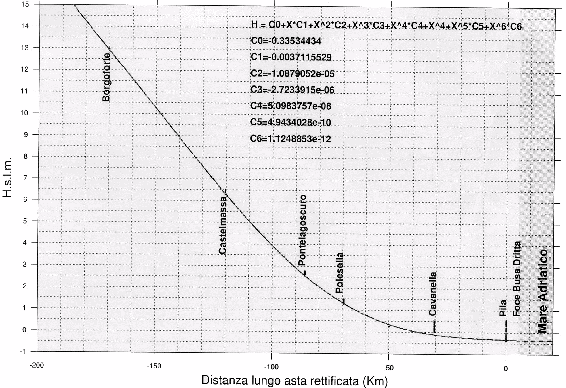
Fig. 1.4d - Profilo di massima magra del Po interpolato in funzione della distanza dalla foce ( Pila). Dati degli idrometri telerilevati di Borgoforte, Castelmassa, Pontelagoscuro, Polesella, Cavanella, Pila (barre scure) (cortesia del Magistrato del Po a Parma, letture 26-26 luglio 1997, 25-27 marzo 1998). Sono riportati anche i coefficienti del polinomio interpolante di 6o grado.
La Convenzione per la realizzazione del progetto è stata definita da A. Bernasconi, C. Dedè, R. Fantoni, R. Servodio (ENI-Div. AGIP), F. Frascari, M. Roveri (CNR/Istituto di Geologia Marina di Bologna), R. Pignone e G. Di Dio (Regione Emilia-Romagna/Programmazione e Pianificazione Urbanistica, Servizio Cartografico).
Alla stesura del Programma operativo hanno collaborato L. Alberico, R. Fantoni, A. Nicora, F. Piccoli e R. Servodio, (ENI-Div. Agip); F. Frascari, M. Roveri A. Bortoluzzi (CNR); G. Di Dio (Regione Emilia-Romagna).
Il piano di navigazione è stato concordato con I. Galvani e G. Rossini (A.R.N.I.), che hanno assicurato la continua assistenza durante tutte le fasi operative.
Le modalità di valutazione dei test di impatto dell’energia rilasciata dall’”air gun” sulla fauna ittica del fiume sono state definite con L. Ceffa e L. Trovarelli (ENI-Div. AGIP) e sono state realizzate sotto la responsabilità scientifica di R. Rossi da B. Dezfuli, O. De Curtis, M. Manera e C. Barbieri (Università degli Studi di Ferrara/Dipartimento di Biologia).
Il rilievo geodetico, batimorfologico e sismico multicanale è stato eseguito dalla società G.A.S. (Geological Assistance & Services, Bologna) sotto la responsabilità di G. Gasparini e la supervisione di F. Zucchini. La G.A.S. ha inoltre fornito la sorgente sismica e gli operatori per l’esecuzione delle prove di impatto ambientale sulla fauna ittica e sugli argini del fiume Po.
Per l’esecuzione delle misure vibrometriche il contrattista si è avvalso del supporto della società Geoitalia (S. Giuliano Milanese, MI).
La ricognizione topografica è avvenuta con la supervisione di F. Pellegri (ENI-Div. AGIP).
L. Alberico e C. Foschi (ENI-Div. AGIP) hanno effettuato la supervisione del rilievo batimorfologico e del rilievo sismico.
L’elaborazione dei dati batimetrici interferometrici è stata curata da I. Gavagni e S. Zanoli; l’interpretazione dei dati batimorfologici è stata eseguita da M.R. Di Florio, S. Melandri e S. Mongardi (G.A.S.).
Le ulteriori elaborazioni batimetriche sono state eseguite da G. Bortoluzzi, M. Ligi e D. Penitenti (C.N.R.).
I dati sismici multicanale sono stati elaborati da di A. Cassis e P. Casamanti (ENI-Div. AGIP).
L’elaborazione dei dati sismici multicanale ad alta risoluzione del primo secondo di registrazione è stata eseguita da M. Ligi (CNR).
L’interpretazione delle linee sismiche multicanale inserite nel testo è stata effettuata da R. Fantoni, G. Lanfranchi (ENI-Div. AGIP) e F. Gamberi (CNR).
La restituzione cartografica in scala 1:5000 è stata curata da S. Melandri e S. Zanoli (G.A.S.).
La realizzazione della documentazione fotografica e cinematografica è stata coordinata da G. Magliocca (ENI-Div. AGIP). Le riprese fotografiche sono di C. Vitello (AGI, Milano). Le riprese cinematografiche sono sono state effettuate dalla Merlino Produzioni (Milano); il montaggio da A. Defiores (CSS, S. Donato).
La realizzazione grafica delle tavole riportanti le sezioni sismiche multicanale allegate al lavoro è di A. Mengotti e M. Turin (ENI-Div. AGIP).
La stesura finale del rapporto, comprendente l’editing e la stampa, è stata curata da M.R. Di Florio, S. Melandri e S. Mongardi (G.A.S.).
La fase di studio di tutte le problematiche geofisiche, ambientali ed operative, ha richiesto circa un anno di lavoro, mentre la fase operativa è stata completata in meno di tre mesi. L’elaborazione di tutti i dati acquisiti ha richiesto poco più di un anno di lavoro.
Di seguito è riportato in dettaglio il calendario dei lavori.
Fase preliminare
1993 Ricognizione sul terreno
Ricerca competenze territoriali e giuridiche
“Pre-enquire” alle varie società di servizi geofisici
Studio di fattibilità
13.12.94 inizio studio di prefattibilità
14.04.95 valutazione del progetto
04.05.95 accettazione del progetto
Fase operativa 1996
|
20 giugno 96 |
Firma della Convenzione tra ENI-Div. AGIP, CNR-IGM e Regione Emilia-Romagna per l’acquisizione di dati, la sperimentazione di metodologie geofisiche e la valutazione del loro impatto ambientale sul Fiume Po |
|
28-29 sett. 96 |
Rilievo topografico |
|
21-30 sett. 96 |
Rilievo batimorfologico (dal Delta ad Ostiglia e ritorno) 300 km |
|
6 nov. 96 |
Valutazione dell’impatto dell’”airgun” su alcune specie ittiche del Fiume Po |
|
11-13 dic. 96 |
Valutazione dell’impatto dell’”airgun” sugli argini |
|
10 dic. 96 |
Inizio dell’elaborazione sismica multicanale in ENI-Div. AGIP |
|
6-20 dic. 96 |
Rilievo sismico (dal delta ad Ostiglia) 150 km |
Nel corso del 1997 sono stati elaborati, interpretati e finalizzati tutti i dati acquisiti.
Personale del rilievo geodetico
|
Responsabile: |
G. GASPARINI |
|
Topografo senior: |
I. GAVAGNI |
|
Supervisori ENI-Div. Agip: |
F. PELLEGRI |
Personale del rilievo batimorfologico
Personale a bordo
|
Navigatore: |
A. BOSCHETTI |
|
Ingegnere elettronico: |
O. DEL VECCHIO |
|
Tecnico elettronico: |
F. PAGLIERANI |
|
Operatore Chirp: |
F: CERNICH |
|
Operatore Swath Bathymetry: |
S. VIANELLI |
|
Supervisori ENI-Div. Agip: |
L. ALBERICO C. FOSCHI |
Personale a Terra
|
Shoremen: |
M. BASCIANO A. PICCHIANI |
Personale del rilievo di impatto ambientale sulla fauna ittica
|
Responsabile delle Operazioni Sismiche |
F. ZUCCHINI |
|
Tecnico Sorgente Sismica |
S. ZANOLI |
|
Gun Mechanic |
J. MARSDEN |
|
Responsabile Scientifico Università degli Studi di Ferrara Dipartimento di Biologia |
R. Rossi |
|
Interpretazione ed Elaborazione Dati Università degli Studi di Ferrara Dipartimento di Biologia |
B. S. Dezfuli O. De Curtis M. Manera S. Onestini C. Barbieri I. Ludergnani A. Carrieri S. Volponi |
Personale del rilievo di impatto ambientale sugli argini
Le misure vibrometriche sono state eseguite in corso d’opera dal personale della G.A.S. in collaborazione con i tecnici della Geoitalia.
Personale del rilievo sismico multicanale
Personale a bordo del Pontone “Silvia”
|
Capomissione: |
F. ZUCCHINI |
|
Navigatori: |
M. ALEOTTI F. CERNICH |
|
Operatori Sismica Multicanale: |
S. SHIPLEY |
|
Gun Mechanic: |
J. MARSDEN |
|
Supervisore ENI-Div. Agip: |
C. FOSCHI |
Personale a bordo del S/V “Maria Adelaide”
|
Ingegnere Elettronico/Pilota |
O. DEL VECCHIO |
|
Assistente: |
A. PICCHIANI |
Personale a Terra
|
Shoremen: |
M. BASCIANO S. EMALDI |
|
Addetti al Processing: |
I. GAVAGNI
S. ZANOLI |